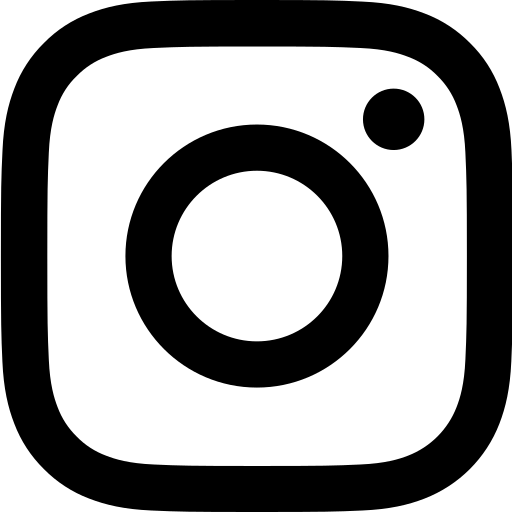Tra le parole misteriose della profumeria spicca ”aldeidica”. Per un chimico questo termine indica semplicemente un gruppo funzionale, aldeidico appunto, che deve il suo nome (dal latino alcohol dehydrogenatus) al fatto che si può ottenere per ossidazione (o deidrogenazione) dei corrispondenti alcoli e l’odore delle aldeidi può spaziare dalle puzze più fastidiose, pensiamo ad esempio alla formaldeide usatissima in passato come disinfettante negli ospedali, agli aromi più piacevoli, ad esempio la vaniglia, il latte di mandorle, la liquerizia e la cannella che devono il loro odore proprio a delle aldeidi. In realtà questo termine in profumeria si riferisce principalmente a un gruppo limitato di aldeidi molto semplici, dette alifatiche, sostanzialmente descrivibili come dei piccoli serpentelli la cui testa è fatta di un atomo di ossigeno e la coda composta da una catena relativamente corta di atomi di carbonio, da 6 a 18. Sono piccole molecole molto flessibili, con nessuna rigidità strutturale e molto delicate perché soggette a ossidarsi anche solo a contatto con l’aria, producendo dei fratelli maggiori (acidi carbossilici) che spesso hanno odori decisamente poco piacevoli come fanno intuire alcuni dei loro nomi: butirrico, caprilico, caprinico.
Le aldeidi alifatiche sono state utilizzate agli inizi del ‘900 in profumeria perché, oltre al contributo dato dalla loro propria fragranza, hanno la caratteristica di potenziare e rendere più frizzanti, cristalline, trasparenti e glaciali le note floreali. In particolare abbinate a essenze di gelsomino, rosa, iris o mughetto le rendono meno grevi e più leggiadre con aspetti lievemente metallici e freschi. Hanno anche la capacità di rendere più persistenti e duraturi i profumi, in particolare quelli floreali, agendo quindi anche da fissativi.
Questo gruppetto di molecole ha sempre creato un certo imbarazzo agli scienziati perché il loro profilo olfattivo sfugge alle usuali interpretazioni di struttura-attività e non si riesce a comprendere come ad ogni aggiunta di un semplice atomo di carbonio in una struttura così poco rigida cambi sensibilmente l’odore percepito.
Guy Robert, nel suo libro, Les Sense du Parfum (1) scrive che le aldeidi hanno prevalenza di note fruttate se il numero di atomi di carbonio è pari, mentre prevalgono le note floreali in quelle a numero di atomi di carbonio dispari. A partire dai 14 atomi di carbonio le aldeidi a numero di carboni pari hanno caratteristici odori di frutta mentre, altro piccolo mistero, quelle dispari sono inodori o quasi.
Queste aldeidi sono assolutamente naturali e presenti ad esempio nelle essenze e nelle scorze degli agrumi, nelle essenze di rosa, di pino, di citronella e nella scorza della cannella ma, data la loro bassa concentrazione e la labilità intrinseca, molto raramente vengono ottenute dalle materie prime naturali che le contengono e vengono prodotte, come d’altra parte avviene in natura grazie all’enzima deidrogenasi, per ossidazione dei corrispondenti alcoli, facilmente reperibili e poco costosi.
Chanel N° 5
E’il profumo che più di tutti le ha portate alla ribalta, in particolare le aldeidi C10, C11 e C12, realizzato da Ernst Beaux nel 1921 per Coco Chanel.
Le aldeidi di Chanel N°5
Lo scopo era di fare in modo che il gelsomino e la rosa di Grasse non risultassero così floreali, perché si desiderava: “un profumo che sapesse di donna e non di fiori, perché le donne non vogliono profumare come un letto di rose”. Il messaggio pubblicitario nel 1955, fece poi riferimento esplicito a questa frase, facendo dire a Marylin Monroe: “cosa indosso a letto? Chanel N°5 ovviamente! ”. Curioso il destino! Chanel N°5, pur essendo l’archetipo dei profumi aldeidici, è spesso considerato come l’interpretazione più realistica e sensuale di un bouquet floreale.
- Les Sens du Parfum – I sensi e l’essenza del profumo-di Guy Robert- FrancoAngeli Editore ISBN 88-464-4302-0